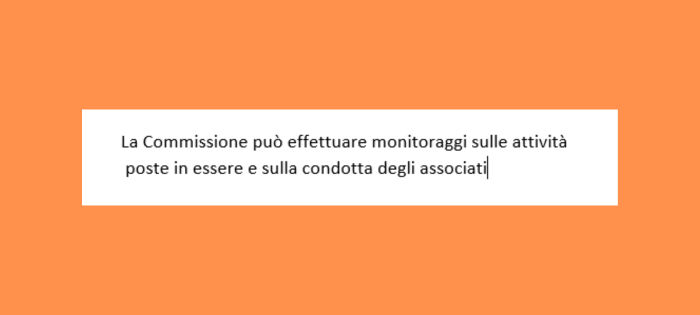«Non si può ritrarre l’intera vita di un uomo in due ore, ma solo provare a darne un’impressione», dice Herman J. Mankiewicz, anticipando l’indimenticabile battuta «La vita di un uomo non si può spiegare con una sola parola» del leggendario Quarto potere, che ha contribuito a creare. Un frammento di Mank di David Fincher, da qualche mese nel catalogo Netflix, che racconta molto di un’operazione nata con l’intento di addentrarsi nei retroscena del capolavoro di Orson Welles ma in grado di indagare anche su molto altro, come gli intrecci fra politica e industria dell’intrattenimento, la ciclica necessità da parte del cinema di rinnovare e rinnovarsi, la capacità delle immagini di influire sull’esito di un’elezione e soprattutto il punto di vista sul processo creativo degli sceneggiatori, rappresentati dal Mankiewicz di un sontuoso Gary Oldman e di riflesso da Jack Fincher, defunto padre del regista e autore dello script. Quello dello sceneggiatore è il punto di vista non solo sulla genesi del film, ma anche sull’industria di Hollywood, della quale emergono vizi, bassezze e contraddizioni. Costretto a letto con una gamba rotta, Mank ha davanti a sé 90 giorni (ridotti poi a 60 da Welles) per elaborare una sceneggiatura che è la sintesi della sua esperienza nella fabbrica dei sogni.
Mankiewicz è annoiato, disilluso, consumato dall’alcolismo. Un uomo poco più che quarantenne, che ne dimostra almeno 20 di più, grazie anche alla performance quasi tutta in sottrazione di Oldman. La narrazione non è circoscritta al suo processo creativo, ma si spande nel dietro le quinte, nei giochi di potere che governano l’industria e negli incontri con i tanti pittoreschi personaggi che popolano questo sottobosco. Fra continui salti avanti e indietro nel tempo, scopriamo di più su Mank, sul suo percorso a Hollywood, sul suo rapporto con la rassegnata moglie (“la povera Sara”, come la chiama lui) e sulla sua problematica collaborazione con lo stesso Welles (impersonato da un sorprendente Tom Burke), che ci viene presentato come un personaggio tronfio e cinico al punto da sfruttare la calante popolarità dello sceneggiatore per proporgli un avvilente accordo volto a intestarsi totalmente la paternità di Quarto potere.
Fincher tratteggia un Mankiewitz sconfitto su tutti i fronti, salvo quello della creazione intellettuale. E sarà proprio la scrittura a permettergli di redimersi e di prendere la sua rivincita contro il potere finanziario e dei media. In Quarto Potere William Randolph Hearst diventa Charles Foster Kane, e la sua immaginifica magione di Saint Simeon viene trasposta nella fantastica Xanadu, dove alla fine muore da solo, abbandonato da tutti. Un Mank che alla fine rimane ancorato all’immagine dell’intellettuale di alto livello che si oppone alla cultura popolare, bene riassunta nella sua battuta: “Vieni a Hollywood, puoi guadagnare milioni e i tuoi unici rivali sono degli idioti”. E forse questo film è stato concepito proprio per un pubblico di intellettuali e di cinefili.
Inutile dirlo, Mank non sarebbe stato lo stesso se non fosse stato girato in bianco e nero, ma il mero filtro alla visione non sarebbe al contempo bastato per avere un’esperienza completa, nonostante l’ottima fotografia e i magnifici contrasti luce/ombra che analizzano l’atmosfera quasi noir del film, e David Fincher è una persona attenta ai dettagli e che conosce molto bene il suo lavoro: l’audio, infatti, è permeato da un effetto eco così ben fatto che non si capisce se sia voluto o se effettivamente abbiano usato strumenti di registrazione antiquati.
Le musiche ovattate e soffuse sembrano uscire proprio da un film noir di quegli anni, e anche i piccoli ma visibili dettagli sulla pellicola, come le bruciature di sigarette, i capelli o il rumore della bobina girata contribuiscono a dare a questo film un’estetica antiquata, ma nel senso piacevole della parola. Se aggiungiamo anche una regia che strizza l’occhio alla vecchia guardia, con riconoscibilissime inquadrature dal basso di cui conosciamo tutti l’autore, piani medi ripresi a telecamera fissa e campi-controcampi serrati, dettagli serrati, campi sovrapposti o dialoghi recitati rapidamente e a voce alta per farsi sentire dai vecchi microfoni, è palese quanto chi abbia creato questo film sia un amante del cinema classico.
Chiara Napoli