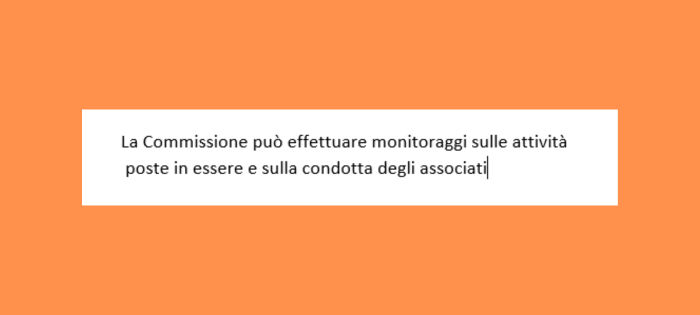Una canzone poco conosciuta del cantautore napoletano Giovanni Truppi recita che “il mondo è come io me lo metto in testa”, ed è un’immagine estremamente esplicativa di quanto le immagini che abbiamo del mondo possano essere poco aderenti alla realtà, distorte. L’esperimento del sociologo Erving Goffman del “non pensare ad un elefante” urlato in un’aula universitaria è il momento che ha condotto lo stesso a sviluppare l’idea di framing, uno schema interpretativo per raccontare la realtà a cui chiunque accede per categorizzare parole e frasi. Una vera e propria confezione ben costruita con all’interno dei significati. Tuttavia, per quanto l’attività personale abbia ingerenza sul modo di guardare il mondo, il racconto collettivo di un fenomeno è l’esempio di quanto l’umanità sia fatta di cultura. Come Goffman abbia urlato la parola elefante impedendo ai/le presenti di non pensarla, così gli schemi culturali si propagano senza soluzione di continuità, attraverso spazi di ampio raggio, per raccontare una realtà diversa da quella che dovrebbe essere.
L’elefante sono i bias, la narrazione mediatica è la confezione. Più che “il mondo è come me lo metto in testa”, è “il mondo è come me lo mettono in testa”, modificando la percezione del circostante. Nel 2021, la Turchia lasciava la convenzione di Istanbul sulla violenza di genere e il Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, finanziava la stesura di un volume “Stereotipo e pregiudizio: La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere” edito da Franco Angeli e a cura della docente universitaria Flaminia Saccà, che ha curato il capitolo “Tre volte vittima. Uno sguardo d’insieme sulla rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere” portando avanti un progetto insieme all’Associazione Differenza Donna “che intervenisse sulla cultura per disvelare gli stereotipi e i pregiudizi che soggiacciono alla rappresentazione sociale della violenza di genere”. Secondo la docente, l’unico modo per cercare una soluzione alla violenza di genere è inquadrare il framing del problema, la cornice interpretativa portata avanti da sentenze e articoli di giornale. Se il quadro d’interpretazione è distorto e patriarcale, la soluzione lo sarà altrettanto.
Analizzando un database di 16.715 articoli afferenti a 15 testate per gli anni 2017, 2018 e 2019, è possibile notare quanto alcuni reati estremamente diffusi relativi alla violenza di genere siano marginali per la stampa. Solo il 14 % degli articoli è dedicato ai maltrattamenti familiari, nonostante le denunce siano pari al 51,1%. Il reato più raccontato dai giornali è lo stalking, che è, al contrario, il meno denunciato dalle donne. Si tratta della prima focalizzazione errata dei media, più propensi a raccontare un tipo di denuncia che non preveda una violenza fisica. Al secondo posto il femminicidio, al terzo posto il già citato stalking, all’ultimo lo stupro (9,8%). Questa manipolazione, spesso consapevole, della realtà da parte del giornalismo italiano, tende a sminuire una realtà estremamente diffusa come la violenza domestica. Se questa non è raccontata, non sembra esistere, è di difficile riconoscimento e viene percepita come norma, non come devianza.
L’ultima parte dell’analisi colpisce con precisione l’obiettivo della ricerca: le parole. Attraverso una ricerca interna al database, è stato possibile creare una word cloud, una nuvola di parole più ricorrenti, un esercizio noto al mondo dei social per individuare i termini più frequenti all’interno di testi e di motori di ricerca. L’autrice ha deciso di intitolare la nuvola “Trova il colpevole”, un ossimoro rispetto al risultato della ricerca: nella word cloud, il colpevole non c’è. Le parole in evidenza sono “donna”, “donne”, “violenza”, “stalking”, “Carabinieri”. Le parole più piccole, difficili da mettere a fuoco e rarissime, sono “marito”, “uomo”, “compagno”. Gli autori delle violenze. I soprusi, in questo modo, tendono a sembrare un qualcosa che capita alle donne, ma senza che qualcuno li metta in atto. I titoli dei giornali mostrano invece un capovolgimento della relazione tra colpevole e vittima. La seconda diventa colei che ha colpa del reato subito. La ricerca porta ad esempio due titoli esplicativi di due testate celebri: Il Messaggero e il gruppo Today. In entrambi i titoli, si tende a sottolineare il carattere della donna uccisa, l’ubriachezza di quella stuprata.
Dai dati raccolti, il risultato della ricerca (che dà il titolo al capitolo in questione) è la triplice vittimizzazione della donna in caso di violenza:
– vittimizzazione primaria, perché vittima della violenza subita;
– vittimizzazione secondaria, perché dipinta dalla stampa e spesso dall’ambito giudiziario come colpevole;
– vittimizzazione terziaria, perché da un quadro distorto deriva una giustizia distorta, depotenziata da questa narrazione.
In questo terreno culturale, la donna non ha ruolo, né possibilità di agire, non ha spazio, non è protagonista nemmeno della violenza subita o, spesso, ne è personalmente responsabile a causa di pregiudizi ideologici a cui tutte le categorie interne all’ambito giudiziario e mediatico partecipano: la polizia, gli avvocati, i magistrati, i testimoni.
Il fatto non è più attendibile, è soltanto uno strumento per tutelare il proprio privilegio. “Se si riconoscessero e abbandonassero gli stereotipi”, scrive Flaminia Saccà, “e si restasse ai fatti non si faticherebbe a riconoscere la responsabilità dell’aggressore e giustizia alla vittima. Si sarebbe meno esposti al rischio di distorsione che il pregiudizio comporta e si vedrebbe rafforzata la capacità di giustizia del Paese. Per le donne, certamente, ma non solo. Anche per la dignità dello Stato e per la qualità democratica delle nostre istituzioni”.