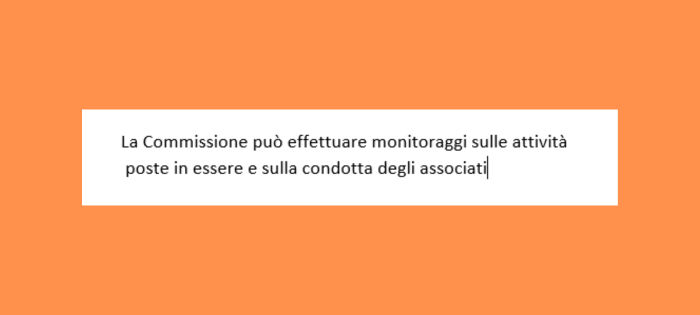“In che modo potremo mai noi scrittori di fiction chiedere il ‘permesso’ di usare un personaggio appartenente a un’altra razza o cultura, o utilizzare il gergo di un gruppo a cui non apparteniamo? Mettiamo su un gazebo all’angolo e avviciniamo i passanti con una cartellina per raccogliere firme che ci attribuiscano il diritto illimitato a usare un personaggio indonesiano nel Capitolo Dodici, un po’ come fanno i volontari delle campagne elettorali per fare sì che il loro candidato arrivi sulla scheda?”. Risponde così la scrittrice Lionel Shriver durante Brisabane Writers Festival dell’8 settembre 2016 in riguardo alla definizione di Susan Scafidi, docente di legge alla Fordham University, del concetto di “appropriazione culturale”, cioè “l’atto di prendere proprietà intellettuali, sapienze tradizionali, espressioni culturali o manufatti dalla cultura altrui senza permesso”. Potremmo affermare che l’appropriazione culturale sia un semplice effetto collaterale della globalizzazione, tra pettinature afro e treccine per affrontare le stagioni estive, un kimono su Shane a 9,90, il sushi ingurgitato la scorsa settimana. È la libera diffusione culturale, estetica, spirituale di immagini che non appartengono all’imperante cultura occidentale. Eppure l’uso sfrenato di simboli rappresentativi di culture alternative ha sempre destato, nelle civiltà “derubate” dalle logiche di marketing, una certa indignazione, derivante dall’idea che quei gesti, quei capelli, vestiti, utensili, tatuaggi vengano completamente svuotati dal significato che quel popolo, dopo lotte e sfruttamento, ha attribuito a quei simboli.
Dopo i primi venti minuti dell’intervento della Shriver, Yassmin Abdel-Magied, attivista, abbandona la conferenza rispondendo in un lungo post su Medium con queste parole: “Non è sempre accettabile che un uomo bianco scriva la storia di una donna nigeriana perché la donna nigeriana vera e propria non riesce a trovare un editore o a farsi recensire. Non è sempre accettabile che una donna bianca eterosessuale scriva la storia di un uomo indigeno non eterosessuale, perché quando è stata l’ultima volta in cui avete sentito un uomo indigeno non eterosessuale raccontare la sua storia? […] Non è sempre accettabile che la persona che gode del privilegio dell’istruzione e della ricchezza sia nelle condizioni di scrivere la storia di un giovane indigeno, filtrandone l’esperienza attraverso la loro lente deformata e deformante, raccontando una storia che probabilmente andrà a rafforzare una narrazione pre-esistente che serve solo ad approfondire uno svantaggio che questa persona non sarà mai nelle condizioni di sperimentare…”. In Italia, il dibattito riguardante l’appropriazione culturale si è aperto soltanto negli ultimi anni in parallelo ai fenomeni di immigrazione, alle realtà appartenenti alle seconde generazioni attive sul web, agli scandali e alle “disattenzioni” commesse da grandi star della moda, della musica pop o del makeup. Ma quante ragazze piene di rasta e treccine e baldi giovani con un tribale sulla schiena vagheranno per le nostre spiagge dopo aver postato su Facebook l’ennesimo post pro Lega? Quante ragazze indosseranno il kimono comprato su Shane nel verso sbagliato, con le bacchette del sushi-bar infilate nello chignon?
Il livello raggiunto dalla star Kim Kardashian, già accusata di cultural appropriation per la copertina di Vogue India, è però inequiparabile. La Kardashian ha infatti lanciato la sua nuova linea di lingerie modellante per tutte le taglie e per tutte le tonalità di pelle. Lei stessa ha denunciato l’assenza sul mercato, fino a qualche tempo fa, di biancheria intima adatta alla sua colorazione, dedicando la nuova linea proprio a chi, come lei, ha avvertito l’esclusione da un certo tipo di mercato. La nuova collezione si chiama “Kimono”. Un rimando all’oriente? Lo stile asiatico è completamente assente dal suo prodotto, si tratta di un semplice gioco di parole tra il suo nome e l’abito giapponese. La risposta del Sol Levante è del tutto prevedibile: l’attaccamento alle tradizioni della nazione ha generato indignazione in tutto il Giappone, completamente contro la strumentalizzazione dell’abito tradizionale usato per una campagna di marketing del tutto distante da quel tipo di abbigliamento. L’hashtag #kimono si trasforma immediatamente in #KimOhNo, spopolando sul web. Nonostante i buoni propositi di Kim Kardashian, la risposta asiatica non ha tardato a farsi sentire. Già nel 2015, il museo delle belle arti di Boston fu costretto a cancellare l’esposizione dedicata al kimono dopo l’accusa di appropriazione culturale da parte di protestanti e attivisti, che hanno definito la mostra come “un insulto per le nostre identità, esperienze e storie in qualità di asiatico-americani in America” che “colpisce il modo in cui tutta la società continua a rinchiuderci in stereotipi e a ignorare le nostre voci”.
Può un abito che racchiude in sé lunghissimi rituali, che ha seguito per secoli i ritmi della natura, armonizzandone i colori con essa, che è diventato il simbolo di una società estremamente legata alla propria cultura, diventare impropriamente il nome di una linea di lingerie? Se non è appropriazione culturale, rientra sicuramente in una delle peggiori operazioni di marketing della nuova generazione influencer.
Maria Vittoria Santoro