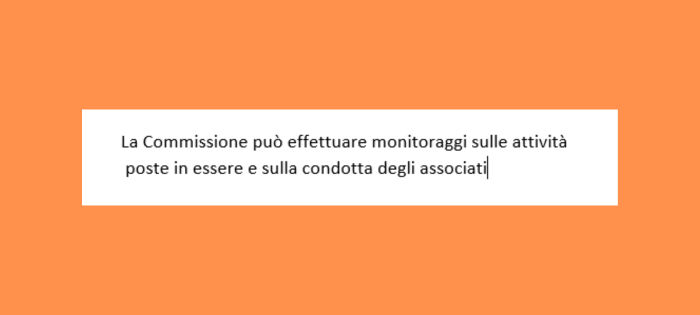C’è un luogo che ad un anno a questa parte è divenuto inaccessibile per chiunque abbia dai diciannove anni in sù. Uno spazio a cui è stato difficile rinunciare e di cui ancora oggi si sente fortemente la mancanza. Aveva tutto ciò che può servire a chi vuole studiare: una sedia, un banchetto e silenzio. Pochi elementi strutturali, ma talmente fondamentali (e rari) da costringere decine e decine di ventenni ad appostarsi fuori all’edificio mezz’ora prima l’orario di apertura solo per assicurarsi di avere un posticino in mezzo a centinaia di postazioni. L’unico spazio franco, libero, indipendente, privo di fazioni e rivalità all’interno dell’università. Ci si poteva imbattere in qualsiasi personalità: da quella perfettamente organizzata in grado di sottolineare con righello e matita, a quella che alle 11:00 cercava ancora di ricordare il proprio nome. Un via vai di volti, stili, caratteri, sogni e progetti così diversi. Frequentare quel luogo consentiva di conoscere un po’ meglio l’università e in qualche modo sapeva fungere da ispirazione. Ci si poteva specchiare nella costanza e negli occhi stanchi di chi stava di fronte, nel desiderio di raggiungere un obiettivo e accrescere le proprie conoscenze. Era anche un luogo di rifugio e di speranza per chiunque vivesse a casa una situazione difficile capace di incidere fortemente sullo studio. Chiunque abbia avuto modo di vivere quello spazio, lo ha già capito: si tratta della biblioteca.
Ad un anno dallo scoppio della pandemia la biblioteca è uno di quei luoghi che non è riuscito a trovare una nuova forma di sviluppo. La possibilità di creare assembramento, sui mezzi pubblici o negli stessi edifici, pur prevedendo un servizio apposito di prenotazione, ha preso il sopravvento su quello che viene considerata tuttora una grossa esigenza. Studiare ai ritmi di prima, con lo stesso silenzio e la stessa concentrazione è sempre più complicato quando si è in una famiglia numerosa o quando semplicemente non si dispone di una abitazione grande o utilizzata autonomamente. Anche in assenza di questi elementi, diventa sempre più difficile riuscire a raggiungere lo stesso livello di concentrazione di prima nel momento in cui appare complicato separare il lato privato da quello accademico e si finisce per mangiare, dormire, seguire le lezioni, sostenere esami, e preparare esami nelle stesse quattro mura.
Riversarsi nelle biblioteche locali non sempre è possibile. Lo dimostra la pagina “Riapriamo la biblioteca” che da mesi si sta facendo portavoce della richiesta di consentire l’accesso alla biblioteca provinciale di Salerno per le attività di studio prevedendo contestualmente l’ampliamento degli orari di apertura. Una protesta che ha avuto inizio a novembre quando su uno striscione si leggeva “Untori per la movida. Invisibili per lo studio”. Un chiaro messaggio a quello che era divenuto il dibattito pubblico attorno ai giovani durante l’estate 2020: si parlava di discoteche aperte e non si dedicava neanche un trafiletto alle università mai uscite dal primo lockdown (e ora sappiamo: mai uscite dal lockdown), la cui discussione sulle linee guida per una pseudo-riapertura ebbe luogo solo su Twitter. “Le discoteche aperte e le università chiuse” era lo slogan su cui talvolta si è appoggiata la classe studentesca, un modo per esprimere il malessere frutto della consapevolezza che in seguito al primo lockdown si è data l’opportunità di svolgere qualsiasi attività e andare in qualsiasi luogo eccetto l’università. Eccetto investire nei trasporti e nei luoghi di studio per ritornare almeno ad una semi-normalità per quello che riguarda uno degli aspetti fondamentali della vita accademica.
Nel corso degli anni la classe studentesca universitaria dell’ateneo salernitano si è specializzata in quella che comunemente si chiama “l’arte dell’arrangiarsi”. Quando i posti in aula non sono abbastanza, si fa uso dei davanzali o delle pseudo-panchine attorno ai banchi oppure, se proprio non c’è altro, del pavimento. Con i pullman si fa ciò che si può: ci si sta addosso l’un l’altro, si cerca di coprirsi dalla gocciolina d’acqua che cade in testa, si cerca di rinforzare i muscoli delle braccia per potersi aggrappare meglio alle pensiline. Si impara a correre, nel vero senso fisico del termine: anche se non ci sono dati scientifici a sostegno, sappiamo che piazza del rettorato e mensa sono percorribili in meno di tre minuti quando la lezione sta per iniziare o il pullman per partire. Ci si arrangia anche se malauguratamente il cellulare si scarica, se ci si taglia distrattamente. Mancano tante cose dentro i campus ma la classe studentesca se lo è sempre fatto bastare. È che la voglia di studiare, di costruire attivamente il proprio presente e futuro ha avuto un posto più alto nella classifica delle priorità.
Ecco perché chi amava studiare in biblioteca si svegliava (sebbene non volentieri) due ore prima per poter essere lì davanti nel momento dell’apertura delle porte. Ecco perché si sopportava il vicino/la vicina chiacchierone/a, il wifi che non sempre prendeva bene e il caffè annacquato dei distributori. Si poteva sopportare questo e altro solo per poter dire le tre paroline “vado a studiare”. Moto a luogo. Mi muovo per andare lì, dove studio, dove non posso utilizzare il cellulare.
Manca tutto questo. La possibilità di non rispondere al telefono, poter usare quell’espressione di movimento (“vado a studiare” che ci rendeva di nuovo soggetti autori dell’azione), poter vivere un luogo dove le ore che passano vengono utilizzate per nutrire il proprio sé. Uno spazio da vivere intensamente sentendosi tutto il giorno e tutti i giorni appartenente ad una comunità studentesca.
Ora che il cellulare è sempre accanto a noi, utilizzato come forma di evasione della nostra routine in pantofole, che le tre paroline “vado a studiare” si sono trasformate in “provo a studiare”, che non c’è la possibilità di essere certi che domani 8 ore di studio non ce le toglie nessuno, che se chiudiamo la porta e non ci distraiamo con la mente non verremo distratti, tutto è un po’ più sbiadito.
Nei vari tentativi di farci forza, non ci resta altro che la nostalgia di quel luogo. Uno spazio tutto nostro dove, almeno per una volta, avevamo il potere di mettere una linea di confine tra noi che studiamo e tutto ciò che crea interferenza.