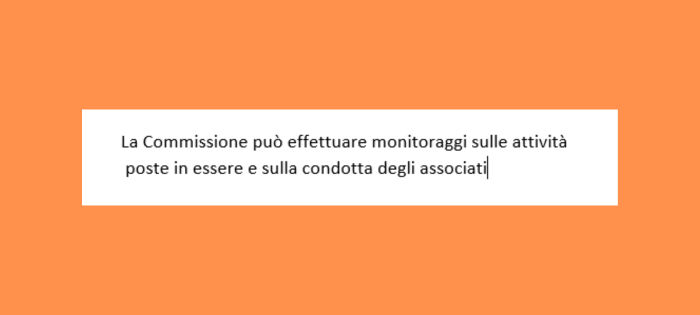Ibanin, frequentemente utilizzato nella forma abbreviata “Iban”. È il risultato di un gioco di parole ottenuto dall’espressione Ilban-in, “persona regolare, comune”, che nella sua forma derivata viene però comunemente tradotta come “persona di seconda scelta, di tipo diverso, di classe inferiore”. La comunità della Corea del Sud, associa la parola Ibanin alle persone omosessuali, dimenticando spesso l’esistenza di un termine corretto: dongseongaeja, letteralmente “amante dello stesso sesso”. La Corea del Sud è il metro di paragone più esemplificativo per comprendere quanto lo stigma sociale, nonostante l’assenza di effettive regole restrittive nei confronti della comunità, possa essere sottilmente ancora più pericoloso delle restrizioni stesse. Non che in Corea la legge tuteli del tutto la comunità LGBT (l’articolo 92 del codice penale militare definisce ancora come molestia i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso senza tenere in conto della consensualità, nonostante la sentenze del tribunale militare ancora al vaglio della Corte Costituzionale).
L’omosessualità in Corea del Sud è ancora un tabù, talmente radicato da spingere le persone appartenenti alla comunità LGBT a nascondere la propria reale identità sessuale o il proprio orientamento sessuale, in modo da riuscire a condurre una vita più semplice in famiglia e sul luogo di lavoro e la vita notturna in quartieri più aperti sembra essere la scorciatoia giusta per riuscire, in un tempo ed uno spazio limitato, a non fingere di essere altro da sé. Itaewon, celebre quartiere della capitale Seoul (ispirando anche l’omonima serie Itaewon Class, disponibile su Netflix) ospita numerose discoteche, bar e locali a luci rosse in cui la comunità LGBT è libera di esprimersi senza alcuna maschera.
La Corea del Sud, anch’essa provata dall’emergenza Covid, ha creato un modello ritenuto da molti estremamente efficace per combattere la catena dei contagi. Grazie ad un serrato tracciamento dei probabili positivi con test sierologici e tamponi a tappeto, abbinati ad un forte controllo sociale, sembra essere riuscita a superare la fase critica molto velocemente. È ora fuori dal lockdown, e la vita sembra essere ripresa con modalità molto simili a quelle precedenti fino agli inizi di maggio, quando un ventinovenne di Seoul asintomatico, dopo aver frequentato un bar e cinque discoteche ad Itaewon, tra cui un gay club, sembra aver prodotto un cluster di contagi più ampio rispetto alla media giornaliera. Il tracking coreano è quindi ripartito con la raccolta di più di 5500 nominativi estorti ai gestori dei locali frequentati, costretti a rivelare identità, numeri di cellulare, pagamenti effettuati nella zona dai loro clienti. Una catastrofe per tutte quelle persone intimorite da un paese estremamente conservatore, abituate a non rivelare la proprie abitudini e i luoghi frequentati per non subire vessazioni, adesso letteralmente sbattuti in prima pagina dal quotidiano legato alla chiesa evangelica Kookmin Ilbo, che insieme ad altre testate ha rivelato nomi e cognomi della persona asintomatica e di numerosi clienti di bar di Itaewon, esposti adesso ad una pesanre gogna mediatica. Dei 5500 contatti, le autorità sono riuscite a comunicare soltanto con 2000. Il resto ha probabilmente fornito dati falsi per non dover comunicare ai propri datori di lavoro il motivo della quarantena forzata. «Se mi faccio il test, la mia impresa scoprirà che sono gay: perderò il lavoro e affronterò una umiliazione pubblica. La mia vita sta per collassare. Non avevo mai avuto istinti suicidi finora, ma ora sì”, ha dichiarato un cliente al The Guardian. L’appello di alcuni media rispetto all’odio palpabile verso la comunità LGBT, e le parole del Premier Chung Sye-kyun rispetto all’inutile perpetrazione di uno stigma che non farà altro che favorire la catena del contagio sembra non essere servito a nulla.
Secondo l’ong Solidarity for LGBT Human Rights of Korea, il comportamento dei media «aggiunge stigma per la malattia all’odio per le minoranze che è prevalente nella società coreana». E lo stigma, la caccia all’untore genera chiusura, isolamento, ghettizzazione, associazione indebita di una comunità ad una malattia che si diffonde senza risparmiare nessun membro di qualsiasi collettività. E durante una pandemia, non è concepibile avere paura di dichiarare il proprio orientamento sessuale per la paura di perdere il lavoro. La discriminazione è ancora la peggiore pandemia presente sul pianeta.
Maria Vittoria Santoro