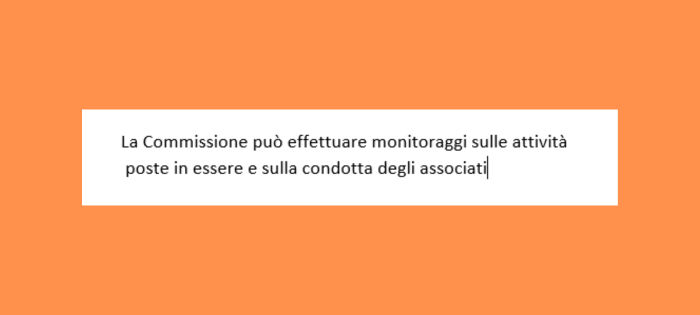“Era come me, poteva vedere. Era come te, sapeva leggere. Era come loro, sapeva parlare. Era un uomo, un uomo portato via, con un crimine che le prigioni gli scrivevano come una ricetta medica”. Per parlare dei campi di concentramento in Cina nella regione dello Xinjiang è necessario (e purtroppo già da diversi anni) partire dalla diaspora, dalla corposa emigrazione di cittadine e cittadini, poetesse, poeti, giornalisti e giornaliste uigure che hanno tentato di sfuggire la repressione delle autorità cinesi per salvaguardare la propria sopravvivenza. I versi appena citati appartengono a Muyesser Abdul’ehed Hendan, poetessa, insegnante e attivista cinese di etnia uigura residente adesso a Instanbul per sfuggire alla repressione. Dopo una laurea in medicina e un master in sanità pubblica, porta con sé e realizza il desiderio di preservare la propria lingua e le proprie tradizioni grazie alla Ayhan Education. Ha già scritto un libro, Addio al Sole, in cui descrive i così detti “campi di rieducazione” in Xinjiang. Rapporti con la famiglia non pervenuti dal 2017. Probabilmente, all’interno di quei campi, l’attivista ha perso tutte le sue radici. La comunità intellettuale uigura sembra già far perdere le proprie tracce a causa delle proprie parole, contando soltanto sulla possibilità che amici e parenti, sopravvivendo, raccontino le loro storie. Perhat Tursun, Idris Nurillah, Shahip Abdusalam Nurbeg, sono soltanto alcuni dei poeti scomparsi in Cina nei campi, citati da Joshua L. Freeman, traduttore uiguro-inglese, in un documento. Un’immagine creata dal collettivo d’arte uiguro Sulu.Artco, mostra una spirale composta dai nomi di scrittori, intellettuali e artisti della regione scomparsi nei campi di concentramento e nelle prigioni. Una marea di nomi. Menti che di parole non vivranno più.
Essere uiguro porta con sé uno spazio di conflitto fatto di resistenza, repressione, maggioranza di potere, divisione per affermare la propria libertà di culto. Un ossimoro, un paradosso rispetto a ciò che le radici etimologiche di questo nome porta con sé. Uiguro vuol dire “alleato”,”unito”. Ed è stato invece già disperso. A maggioranza musulmana, il gruppo etnico rappresenta il 46% della popolazione nello Xinjiang rispetto agli Han, rappresentativi del 92% degli abitanti della Repubblica Popolare Cinese. Il desiderio di indipendenza uiguro e le politiche “anti-terrorismo” cinese, già portarono, nel 2009, ad un terribile scontro tra uiguri e han di matrice dubbia (non è del tutto possibile determinare se lo scontro armato è stato caratterizzato da tendenze terroristiche o dai comportamenti violenti della polizia). L’evento generò un’escalation, da parte del governo cinese, di violazione di diritti umani e cancel-culture legalizzata. Dopo una prima iniziale “campagna strike hard contro il terrorismo violento”, nel 2017 si assiste ad un vero e proprio genocidio culturale nei confronti degli uiguri attraverso divieti d’espressione religiosa. Niente barba lunga, niente velo, niente tv, niente radio, solo scuola statale, zero manifestazioni di culto. I Ramadan divennero segreti, o pretesto per la polizia di esercitare violenza. La presunta volontà di combattere il terrorismo islamico, divenne uno specchietto per le allodole per spegnere la libertà di culto di una fetta del popolo cinese. E la memoria storica che tentiamo di preservare ogni anno con non poche difficoltà, in maniera sterile, nascosti dietro una soffice bambagia di “non potrà mai più accadere” dovrebbe condurre facilmente verso ciò che questo clima di costrizione, nel corso del tempo, genera. L’inasprimento di misure avvenuto in quell’annata ha portato a galla, per la prima volta, la scoperta dei campi di concentramento nello Xinjiang, rinominati dalle autorità come “campi di rieducazioni” e “centri di istruzione formazione professionale”. Il NY times riporta nella sua inchiesta un rapporto della James Town Foundation in cui si evince che i campi fossero già presenti nel 2014 all’interno della regione, prodotti da una politica, a detta delle autorità, di de-estremizzazione religiosa, detta poi “riforma attraverso il lavoro” (definizione non molto distante dai famigerati “campi di lavoro” costruiti anni fa) e poi “trasformazione attraverso l’istruzione”.
Di trasformazione, detenzione, rieducazione e correzione ed altre connotazioni inquietanti se ne è occupato Chen Quanguo, diventato nel 2016 nuovo segretario del partito dello Xinjiang. Inevitabile il suo ruolo nell’idealizzazione dei campi di concentramento cinesi: la sua rieducazione l’aveva già sperimentata in Tibet, segretario di partito anche lì, organizzatore di “meccanismi pervasivi di controllo sociale”. La detenzione uigura è comprensiva di centinaia di migliaia di cittadini, non tutti internati attraverso un processo, reclusi alle volte non solo per la manifestazione del proprio credo, ma per raggiungere un numero cospicuo di detenuti all’interno del processo di “rieducazione”. Le testimonianze raccolte da chi è riuscito a scappare dai campi di detenzione, insieme ad alcuni documenti video raccolti dalla BBC, mostrano uno scenario tremendamente familiare: vagoni claustrofobici di deportati, violenze, schiaffi, pugni, programmi volti alla cancellazione indotta del proprio credo attraverso punizioni, impossibilità di pregare, recitare e cantare a memoria regole e canzoni del Partito, isolamento, privazione del sonno. L’anno scorso, ulteriori testimonianze hanno parlato di interruzione della crescita demografica tramite la sterilizzazione delle donne. Una realtà che diventa narrazione nel momento in cui il governo cinese filtra le informazioni a tal punto da negare l’esistenza dei campi di concentramento o addirittura renderli legali attraverso un velo fatto di disinformazione ed improbabile lotta alla radicalizzazione, tra l’altro stimolata maggiormente dalla repressione di un popolo privato di qualsiasi diritto di esercitare il proprio credo. Nei fasulli campi da lavoro, però, effettivamente si lavora. E questa assurda ed intrinseca legittimità dell’esistenza, di nuovo, di un campo di concentramento, è proprio l’obiettivo a cui questo lavoro aspira. Secondo un’inchiesta dell’Aspi, il sacrificio degli uiguri sostenta almeno 82 noti marchi globali nel settore della tecnologia, dell’abbigliamento e dell’industria automobilistica, tra cui Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung, Sony e Volkswagen, Zara, Adidas etc.
La regione dello Xinjiang è ormai allo stremo, privata della propria identità e dei propri diritti in nome di un massacro fisico, sociale e culturale per ideali ed interessi economici. I campi di concentramento si inseriscono infatti in quel “genocidio culturale” costituito da distruzione di cimiteri uiguri e ricollocazione delle salme in cimiteri approvati dal governo, demolizione di siti religiosi, privazione dell’educazione linguistica e l’eliminazione della cultura letteraria uigura, molto viva fino al 2016 e scomparsa negli anni a venire. Pare che giornali, romanzi, poesie non si trovino nemmeno più sugli scaffali delle librerie. Oltre ad una presa di posizione da parte dell’ONU e del resto del pianeta nei confronti delle politiche dello Xinjiang, in questo preciso momento storico soltanto le voci della diaspora uigura possono salvare l’espressione culturale di un popolo che sembra destinato a sparire. Muyesser Abdul’ehed Hendan è soltanto una delle identità che provano, seppur fuori dalla propria terra, a riemergere e testimoniare lo scempio a cui hanno assistito. Abdukhebir Qadir Erkan, classe 1990, ha scritto le sue liriche più rappresentative sui tovaglioli trafugati in aereo durante la fuga. Fu Nurberg, altro poeta uiguro, il suo mentore. Quando fu incarcerato, scrisse per lui un tributo struggente per un uomo strappato dalla propria realtà. Nel suo scritto, J. Lee Freeman traduce alcuni suoi versi: “Lascia che la lingua che si oscurava mentre i suoi capelli diventavano bianchi fosse una tomba nel tempio in rovina della sua anima. Fai una bara dalla lavagna che gli ha mangiato i polmoni, mentre lo piangiamo, lascia che sia la nostra scia.” -3 agosto 2017-.
Maria Vittoria Santoro