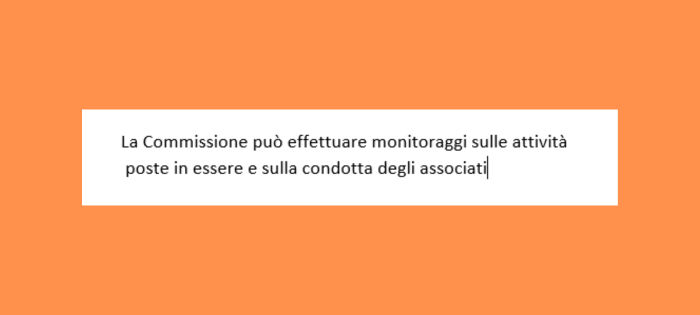“Mea culpa” dovrebbe essere la risposta di molti paesi occidentali quando sentono parlare della crisi umanitaria nello Yemen. La distruzione, la povertà, la fame, la carestia, l’assenza di assistenza sanitaria non sono lì per caso, ma sono la diretta conseguenza degli innumerevoli interessi che lì si stanno perseguendo. Ad oggi sono così tanti gli attori protagonisti, che si fa fatica a capire chi davvero sta combattendo e per quale scopo.
Le ostilità sono nate originariamente come conflitto interno quando nel 2014 il governo yemenita ha arrestato 800 persone appartenenti ad un gruppo armato sciita che aveva organizzato delle manifestazioni per denunciare la corruzione e le posizioni filo-statunitensi dell’amministrazione centrale. Gli appartenenti a questa organizzazione sono chiamati houthi e la comunità internazionale li riconosce come ribelli.
Il 26 Marzo 2015 si verifica la prima grande ingerenza nel conflitto: l’Arabia Saudita insieme ad Egitto, Giordania, Marocco, Sudan comincia i bombardamenti aerei con lo scopo di arrestare l’avanzata degli oppositori del governo e decidendo di prendere parte insieme, tramite coalizione, agli scontri attraverso il costante lancio di raid. Lo Yemen Data Project, osservatorio indipendente, relativamente alle attività condotte dalla coalizione araba, ha parlato di una media di 15 raid giornalieri e di 16mila operazioni aeree dove il 31% di queste non ha colpito obiettivi militari. All’interferenza araba si è aggiunta quella americana degli Stati Uniti, i quali hanno deciso di appoggiare l’Arabia Saudita, e quindi il governo centrale, perché si sospetta che a sostenere gli houthi vi sia l’Iran.
Ad oggi quindi lo Yemen non è più un paese dove si sta verificando un conflitto civile, non è più una terra contesa tra due fazioni che vorrebbero imporre due modi di vivere diversi, ma è teatro di guerra e di interessi per altri Stati, i cui cittadini non risiedono in quella regione e i cui abitanti non rischiano di morire di fame o di colera da un momento all’altro. Tra questi Stati rientriamo anche noi. Rientra anche l’Italia.
A denunciare il ruolo protagonista dell’Italia è stato il New York Times che ha ricostruito la strada attraverso la quale gli armamenti vengono fabbricati e portati fin dentro lo Yemen. Lo stabilimento, della RMW, si trova in Sardegna. I suoi affari vanno così bene che recentemente ha chiesto al Comune di Iglesias di avere in concessione edilizia altri terreni per costruire nuovi reparti e aumentare la produzione dei prodotti. Nella vendita estera delle armi, tuttavia, l’Italia non è sola. E gli unici paesi ad aver sospeso l’attività commerciale sono la Germania e la Danimarca. Una decisione che però non è il risultato di una valutazione oggettiva di quanto sta accadendo in Yemen, ma è la diretta conseguenza della notizia della morte del giornalista Jamal Khashoggi (secondo la polizia turca è stato ucciso nel consolato saudita a Istanbul da ufficiali della intelligence saudita). Peccato che i due paesi europei non abbiano voluto intraprendere questa strada prima, quando la comunità mondiale è venuta a conoscenza delle tantissime e ingiuste morti che lì si stanno consumando.
Secondo l’ONU, durante questi tre anni di conflitto, sono stati uccisi 6.600 civili e altri 10.563 sono stati feriti. Altre migliaia di persone sono invece morte per malattie prevenibili. Amnesty International, nella relazione relativa al 2017 e al 2018, ha parlato di uso spropositato della forza da parte di tutte le fazioni, sia interne che esterne. È chiaro dunque che non si sta combattendo più per la realizzazione di un potere libero, per la propria autodeterminazione. Non si combatte più per il popolo, per il paese, ma per interessi minori. Di fatto c’è una popolazione civile lasciata a sé, per la quale non combatte nessuno. Né il governo centrale, né i ribelli, né la coalizione araba, né l’Europa. Questi soggetti sono invece diventati fautori della invivibilità dello Yemen. Lo dimostra anche la strumentalizzazione che le parti in lotta stanno facendo di Hodeidah: l’unico passaggio utilizzabile con il quale è possibile prestare soccorso alla comunità civile. Proprio questa città portuale, l’unica ancora di salvezza di una terra martoriata, sta diventando oggetto di contestazioni violente e di possibile distruzione. Quello che sembrava essere un conflitto interno si è trasformato in uno scontro internazionale e in modo violento sta avendo delle ripercussioni gravissime sulla popolazione civile. “Mea culpa”, pertanto, dovrebbe essere la risposta della silente comunità mondiale difronte ad un popolo che sta lentamente scomparendo.
Antonella Maiorino